Il Foro Romano
 Il Foro Romano - Roma
Il Foro Romano - Roma
Il Foro Romano, noto in latino come Forum Romanum e dai romani come Forum Magnum o semplicemente Forum, è un sito archeologico di Roma. Si trova tra il Palatino, il Campidoglio, la Via dei Fori Imperiali e il Colosseo. L'area contiene strati di resti di diversi periodi storici e per gran parte della storia dell'antica Roma è stata il cuore politico, giuridico, religioso ed economico della città, nonché il punto focale dell'intera civiltà romana.
Dall'età reale fino all'alba del Medioevo, il Foro fu teatro di eventi e istituzioni di tale importanza da plasmare ripetutamente il corso storico della civiltà occidentale e da esercitare una notevole influenza sulle fondamenta politiche, giuridiche, culturali e filosofiche del pensiero occidentale.
Dopo un periodo di decadenza iniziato nella tarda antichità, il Foro subì frequenti saccheggi e cambiamenti di funzione, che portarono al suo quasi completo seppellimento nel XVI secolo, quando fu trasformato in un pascolo per il bestiame, guadagnandosi il nome di Campo Vaccino.
Spinta da un rinnovato e crescente interesse per la ricerca storica e archeologica alla fine del XIX secolo, insieme alla vasta riqualificazione urbana che ha caratterizzato l'Italia post-unitaria e fascista, l'area del Foro è stata gradualmente riportata alla luce e studiata, diventando infine uno dei siti archeologici più famosi e visitati al mondo, insieme al Colosseo e al Palatino.
Il Foro Romano è stato il primo sito archeologico al mondo ad essere scavato ed è ancora oggi uno dei siti archeologici più importanti al mondo.
 Il Foro Romano - Roma
Il Foro Romano - Roma
Le origini
Dal X al VII secolo a.C., la desolata valle paludosa del Foro fungeva da cimitero per i primi villaggi che si insediarono sulle colline circostanti. Come riportato da Tacito, non era solo questa vasta pianura a ospitare il Foro, ma anche il Campidoglio, che fu unito da Tito Tazio in quello che divenne noto come il quadrilatero di Romolo (Palatino). Gli scrittori antichi, tra cui Tito Livio, raccontano che poco dopo la fondazione di Roma, sul luogo dove sarebbe stato costruito il Foro, ebbe luogo una grande battaglia tra i Romani e i Sabini: è nota come la battaglia del Lago Curzio.
I principali protagonisti di questo conflitto furono la vergine vestale Tarpea, figlia di Spurio Tarpeio, che comandava una fortezza romana nelle vicinanze. Dopo essere stata corrotta con dell'oro da Tito Tazio, convinse un gruppo di uomini armati a entrare nella sua fortezza sul Campidoglio. I Sabini conquistarono questa fortificazione e così entrambi gli eserciti poterono radunarsi ai piedi di due colline (il Palatino e il Campidoglio, dove in seguito sorse il Foro Romano ). Entrambi i generali ebbero il tempo di organizzarsi per la guerra: Mevio Curzio per i Sabini e Osto Ostilio per i Romani. Circondato da montagne, il campo di battaglia non lasciava alcuna via di fuga all'esercito nemico né spazio per inseguirlo. Fu durante questa battaglia che Romolo, vedendo le sue truppe in ritirata, fece un voto a Giove: se avesse vinto, gli avrebbe costruito un tempio sul luogo dove oggi sorge il Foro Romano.
La tradizione vuole che si gettò nel mezzo della battaglia e, con uno sforzo straordinario, ribaltò le sorti della giornata a suo favore, impadronendosi delle rovine di Regia e del Tempio di Vesta. Il primo fu costruito pochi anni dopo. A quel punto le donne, quelle stesse donne sabine che erano state rapite dai Romani, si precipitarono sul campo di battaglia con le lance contro il campo nemico. Cercò di dividere i due schieramenti e placare la loro ira. Questo gesto portò alla firma di un trattato di pace, che creò un'alleanza interetnica che unì i due regni trasferendo il potere decisionale a Roma.
Il lago vicino al Foro Romano è chiamato Lago Curzio in onore di questa battaglia e del comandante sabino Mevio Curzio, che sfuggì per un soffio alla morte. L'Impero Romano non fu completamente costituito fino al 600 a.C. circa. Nel IV secolo a.C., durante il regno del re etrusco Tarquinius Priscus, la valle fu bonificata e fu costruita la Cloaca Maxima, pavimentata con tufo. È questo foro rettangolare, nel cuore della città, che era considerato sia un mercato che il centro della vita politica e giuridica. Era attraversato da molte strade importanti, la più importante delle quali era la Via Sacra, che correva dalle pendici del Campidoglio all'Arco di Tito.
 Il Foro Romano - Roma
Il Foro Romano - Roma
Periodo reale
Il Comizio è riconosciuto come il più antico centro della vita politica, con monumenti arcaici risalenti alla seconda metà del VI secolo a.C. Questi erano collocati in una sala orientata verso i punti cardinali, all'interno dell'area pavimentata con pietre nere nota come Lapis niger, dove, secondo la leggenda, morì Romolo.
È qui che è stata rinvenuta la più antica iscrizione latina mai scoperta, considerata fondamentale per comprendere le tappe dell'evoluzione linguistica e letteraria in Italia, nonostante le analisi del linguista di Alatri Luigi Ceci. Sul lato occidentale di questo Comizio, verso le pendici del Campidoglio, vicino al cosiddetto Umbilicus Urbis, sorge il Volcanale, antico santuario che, secondo la leggenda, fu costruito da Tito Tazio in onore del dio Vulcano.
Dal VI secolo qui si svolgevano le funzioni sacre del Rex sacrorum e del Pontefice Massimo, con una curia chiamata Hostilia, dal nome di Tullus Hostilius, secondo la tradizione. Vi si trovano anche il tempio circolare di Vesta e diversi altri grandi santuari. Tuttavia, ciò che si può vedere oggi è tutto ciò che rimane.
 Il Foro Romano - Roma
Il Foro Romano - Roma
Periodo repubblicano
L'inizio della costruzione del Tempio di Saturno - che ospitava anche il Tesoro (il tesoro di Roma) - e quella del Tempio dei Castori nel 484, dedicato ai Dioscuri, Castore e Polluce, risale all'inizio del V secolo a.C. Nello stesso secolo, più precisamente nel 445, il Lacus Curtius fu consacrato dal console Gaio Curzio Filone. Nel IV secolo a.C., sul lato rivolto verso il Campidoglio, fu costruito il Tempio della Concordia, in adempimento di un accordo tra patrizi e plebei.
La tribuna dei Comizi era adornata da una rostra decorata con le prue delle navi prese dalla flotta della città di Anzio. Nel 210 a.C., Tito Livio scrisse che durante l'edizione notturna della festa dei Quinquatri, un incendio scoppiò in vari punti del Foro. Contemporaneamente, sette botteghe furono distrutte dal fuoco; in seguito ne furono costruite cinque nuove, tra cui quelle degli argentieri. Alcuni edifici privati furono coinvolti nell'incendio, poiché all'epoca non c'erano basiliche nella zona. Anche il mercato del pesce e le prigioni, nonché un atrio appartenente alla Regia, furono vittime dell'incendio.
Con grande sforzo, gran parte del tempio di Vesta fu salvato, principalmente da tredici schiavi che furono immediatamente acquistati con denaro pubblico e liberati. L'incendio durò giorno e notte, poiché apparentemente fu appiccato deliberatamente in diversi punti contemporaneamente; non vi è quindi dubbio che si trattò di un incendio doloso. Una nuova febbre edilizia nel II secolo a.C. trasformò il Foro. Fu Silla a dare inizio alla trasformazione con la costruzione del Tabularium sulla collina, che regolò in modo così armonioso lo sfondo verso il Campidoglio.
Intorno al foro furono costruite quattro basiliche per la giustizia e il commercio: la Portica, l'Emilia, la Sempronia e l'Opimia. La Basilica Emilia è ancora oggi visibile, sebbene sia stata ricostruita più volte, mentre la Porcia e la Sempronia furono sostituite dalla Basilica Giulia, costruita da Cesare ma completata sotto Augusto. Sempre sotto Cesare, la Curia Julia subì un profondo riassetto: invece di mantenere il tradizionale orientamento rituale verso i punti cardinali, fu orientata verso gli assi del vicino Foro di Cesare. Contemporaneamente fu spostata anche la tribuna delle Roste.
 Il Foro Romano - Roma
Il Foro Romano - Roma
L'età dell'impero
Cesare iniziò la progettazione definitiva del Foro, che fu completato all'epoca di Augusto. La piazza assunse una forma più regolare con la costruzione di due grandi basiliche - sui lati lunghi, Emilia e Giulia - e con la Rostra ora collocata sul lato della piazza rivolto verso il Campidoglio. Ora c'è anche un nuovo tempio dedicato al Divino Giulio, che Augusto consacrò nel 29 a.C., poiché Cesare era morto e fu divinizzato solo in seguito. Sull'altro lato più corto del Foro, verso sud-ovest, sorgeva il Tempio del Divino Giulio, qui si trovavano anche l'Arco Partico di Augusto e il portico dell'Arco di Gaio e Lucio Cesare: questi furono quindi sottratti al tanto onorato Regia monumentum et templum Vestae. Questa decisione si inserisce nella fase "cesariana" della sua politica, precedente a una fase successiva caratterizzata da una maggiore cautela ispirata dal conservatorismo.
Questa nuova era di sviluppo imperiale comprende la ricostruzione dei templi che Tiberio eresse nel 10 a.C., apparentemente nel tentativo di cancellare il ricordo delle recenti guerre civili, e anche i monumentali Castori, eretti nel 7 a.C., associati ai fratelli Tiberio e Druso, che creano un legame con i leggendari fratelli Dioscuri. L'iscrizione dedicatoria si trova su una delle estremità della Basilica Emilia dedicata a Lucio Cesare, figlio di Augusto e presunto erede, risalente al 2 d.C.; infatti, erano i portici davanti alla basilica ad essere dedicati sia a Lucio che a suo fratello Gaio Cesare. In sostanza, la piazza rinnovata pullulava di edifici legati alla Gens Iulia per nome, simbolismo o come finanziatori del loro restauro.Il Tempio di Vespasiano ebbe origine vicino al Tempio della Concordia; da allora, un altro tempio è stato costruito fuori dal Foro vero e proprio, lungo la Via Sacra verso Velia: l'Arco di Tito. Probabilmente risale all'epoca di Domiziano. Nelle immediate vicinanze, di fronte alla futura Basilica di Massenzio, si trovano alcuni resti degli Horrea Vespasiani, magazzini ordinati dall'imperatore Vespasiano.
Il tempio di Antonino e Faustina, costruito nel II secolo, fu successivamente incorporato nella chiesa di San Lorenzo in Miranda. Il Tempio di Venere e Roma, costruito durante il regno di Adriano, si affaccia sulla valle dove sorge il Colosseo. All'inizio del III secolo, lungo la Via Sacra fu eretto l'arco di Settimio Severo. Durante il regno di Diocleziano, ai numerosi monumenti che probabilmente riempivano la piazza in quel periodo furono aggiunte cinque colonne su alti basamenti in muratura in onore della Tetrarchia. Nel IV secolo fu iniziata la Basilica di Massenzio, poi completata sotto Costantino I.
Durante il regno di Massenzio, un ingresso circolare al Tempio della Pace, che apparentemente era caduto in rovina, fu adattato per essere utilizzato come tempio, il Tempio del Divino Romolo, dedicato a suo figlio Valerio Romolo, morto giovane. Dopo la sconfitta dell'usurpatore Magnenzio nel 352, il prefetto Nerazio Cereale fece erigere una statua in onore dell'imperatore Costanzo II (il cui basamento è ancora visibile oggi, accanto all'Arco di Settimio Severo verso la Curia). Il Portico dei Dei Consenzienti, sul Campidoglio, fu costruito durante il periodo flaviano e restaurato nel 367. Può essere considerato uno dei monumenti più importanti del tardo paganesimo, insieme all'ultima ricostruzione del Tempio di Saturno.
 Periodo medievale del Foro Romano
Periodo medievale del Foro Romano
Periodo medievale
L'estensione nord-orientale della rostra fu costruita nel V secolo. Questa parte fu ricostruita con muratura molto grezza e presentava una rostra fissata con fori ancora visibili. Un'iscrizione di una sola riga attesta che fu opera di Giunio Valentino, praefectus urbi, durante il regno degli imperatori Leone I e Antemio (circa 470), per una vittoria navale sui Vandali, da cui deriva il nome Rostri vandalici.
Dopo la caduta della città, il Foro perse il suo ruolo storico; gran parte di ciò che rimane oggi è dovuto al successivo riutilizzo cristiano di antichi edifici pagani, come nel caso della Basilica dei Santi Cosma e Damiano, la più antica chiesa rinvenuta nel Foro. La colonna più alta del Foro fu dedicata a Foca dal Senato di Roma nel 608, in onore dell'imperatore. Qui fu costruita anche la Chiesa di Sant'Adriano nel Foro Romano, sopra la Curia Iulia, nel 630.
L'ultima riunione pubblica conosciuta nel Foro ebbe luogo nel 768 davanti alla Chiesa di Sant'Adriano, che ebbe un ruolo fondamentale nel papato di Papa Stefano III. Nei secoli successivi, il Foro subì un grande e costante degrado a causa dell'incuria e dell'abbandono, oltre che del prelievo di gran parte del materiale utilizzato per la costruzione di edifici religiosi. Verso la metà del XII secolo l'accesso al Foro era diventato quasi impossibile, come riportato in un documento sulle processioni e i loro itinerari.
In questo periodo fu redatta anche una prima versione di quello che in seguito sarebbe stato chiamato Mirabilia Urbis Romae; nonostante altre innovazioni, questo testo rimase per oltre trecento anni la principale fonte scritta per ricostruire non solo la topografia della città, ma anche il suo Foro. Il Foro, in gran parte ricoperto di terra, era utilizzato per il pascolo e l'agricoltura a tal punto da essere chiamato "Campo Vaccino".
 Il Foro Romano nel 1880
Il Foro Romano nel 1880
Periodo moderno
Ma la devastazione maggiore avvenne durante il pontificato di papa Giulio II (1503-1513), quando questi decise di utilizzare il sito interamente come cava, fornendo materiali che potevano essere riutilizzati, spesso dopo essere stati trasformati in calce, per il piano di rinnovamento architettonico e artistico che aveva avviato per la città.
Testimoni oculari come Pirro Ligorio hanno affermato che la demolizione dei monumenti fu molto rapida; in alcuni casi, strutture quasi intatte furono demolite in meno di un mese, e le proteste di Raffaello ele preoccupazioni di Michelangelofurono vane. Nel Tempio di Antonino e Faustina, come in molti altri minacciati di distruzione totale, furono rimosse le lastre di marmo con cui era stato decorato e sulle parti superiori sono ancora visibili tracce delle funi utilizzate per tentare di abbattere le colonne. Nell'aprile del 1536 fu deciso che Carlo V avrebbe fatto un ingresso trionfale a Roma, conducendo lui e il suo seguito attraverso il Foro Romano, allora in gran parte sotterraneo.
All'epoca non si conosceva l'esatto percorso della Via Sacra, quindi il percorso scelto per il corteo - una linea retta dall'Arco di Tito all'Arco di Settimio Severo - non aveva alcuna somiglianza con quello antico. Conosciuta oggi come Campo Vaccino, fu riscoperta dagli artisti nel XVI secolo, che trovarono nelle rovine, all'epoca luogo di ritrovo e pascolo, un soggetto molto caratteristico e molto apprezzato dai pittori di paesaggi romani. Nel XVII e XVIII secolo, tuttavia, la strada non era più utilizzata perché le cave erano considerate esaurite e il terreno era utilizzato principalmente per il pascolo.
 Foro Romano Platner nel 1904
Foro Romano Platner nel 1904
I primi scavi scientifici nell'area del Foro Romano furono iniziati nel 1788 dall'ambasciatore svedese Carl Fredrik von Fredenheim, in parte sulla base del lavoro dell'archeologo e storico Johann Joachim Winckelmann. Ciò che fu rinvenuto era parte della Basilica Giulia. Scavi più completi e sistematici furono effettuati nel 1801 da Carlo Fea, archeologo e collezionista d'arte che fu Commissario delle Antichità a Roma per circa trent'anni, sia durante il periodo napoleonico che con la restaurazione del governo papale. A lui si deve lo scavo del Pantheon.
Gli scavi portarono alla luce ampie parti del Foro, ma non erano collegate tra loro. Il progetto generale di riportare alla luce i resti del Foro nel loro insieme fu quindi seguito con più o meno zelo da tre amministrazioni successive: prima quella papale, poi quella della Repubblica Romana e infine quella del Regno d'Italia, che accelerò i lavori di restauro in questa zona. Tra il 1870 e il 1885, famosi archeologi come Pietro Rosa, Giuseppe Fiorelli e Rodolfo Lanciani presero parte al progetto.
Anche il ministro Guido Baccelli ebbe un ruolo importante, poiché permise la rimozione di due strade che attraversavano il Foro, facilitando la sua trasformazione in un unico parco archeologico.
 Foro Romano nel 1880 - Via della Consolazion
Foro Romano nel 1880 - Via della Consolazion
Sotto la direzione di Giacomo Boni, gli scavi effettuati tra il 1898 e il 1904 portarono alla riscoperta di reperti più antichi di quelli precedentemente rinvenuti, la maggior parte dei quali risalenti al periodo imperiale classico. In particolare, questi scavi portarono alla luce la necropoli associata al Tempio di Antonino Pio e Faustina, nonché il Lapis Niger.
Nel 1980, al fine di ripristinare la continuità del percorso tra il Foro e il Campidoglio, fu smantellato il tratto di Via della Consolazione all'interno del Foro, tra le pendici del Campidoglio e il Tempio di Saturno.
Dal 2010 al 2014 sono stati effettuati una serie di studi stratigrafici e spaziali nell'area del Foro tra la Basilica Giulia e il Tempio di Saturno, al fine di indagare il percorso del Vico Iugario. Questi studi hanno portato alla luce la prima parte di una scala, indicando che il secondo piano della Basilica era accessibile alle persone, nonché i resti di un'abitazione risalente al IX-X secolo d.C.
 Edifici del Foro Romano
Edifici del Foro Romano
Edifici e monumenti
Elenco degli edifici e dei monumenti del Foro Romano ancora visibili o non più esistenti:
- Tabularium
- Basilica Emilia
- Sacello di Venere Cloacina
- Tempio di Giano
- Basilica Porcia
- Comizio
- Rostra
- Lapis Niger
- Curia
- Curia Hostilia
- Curia Iulia
- Basi dei monumenti onorifici nel Foro Romano
- Base dei Decennalia
- Arco di Settimio Severo
- Rostra
- Rostra
- Colonna Menia
- Colonna della Rostra di Gaio Duilio
- Ombelico della Città
- Pietra miliare d'oro
- Vulcano
- Tempio di Saturno
- Arco di Tiberio
- Portico dei Consensi
- Tempio di Vespasiano e Tito
- Tempio della Concordia
- Basilica Opimia
- Prigione Tulliana o Mamertina
- Colonna di Foca
- Lago Curzio
- Cavità della statua equestre di Domiziano (Equus Domitiani)
- Basilica Giulia
- Tempio di Augusto
- Tempio di Castore
- Fontana della Giutturna
- Statio aquarum (ufficio dell'acquedotto)
- Oratorio dei Quaranta Martiri
- Complesso di Domiziano nel Foro Romano
- Chiesa di Santa Maria Antiqua
- Horrea Agrippiana
- Tempio di San Giulio
- Arco di Augusto
- Regia
- Arco dei Cesari Gaio e Lucio
- Arco dei Fabi
- Tempio di Vesta
- Casa delle Vestali
- Tempio di Antonino e Faustina
- Necropoli del Tempio di Antonino Pio e Faustina (necropoli arcaica)
- "Prigione" repubblicana (non ci sono prove che fosse una prigione)
- Sacra Via Summa
- Tempio del Divino Romolo
- Portico medievale
- Horrea Piperiana
- Basilica di Massenzio e Costantino
- Arco di Tito
- Tempio di Venere e Roma
- Tracce di una casa repubblicana
- Antiquarium Forense
- Cloaca Maxima (la prima sezione attraversava l'area tra la Basilica Emilia e la Basilica Giulia).
Come leggiamo nel De verborum significatione di Sesto Pompeo Festo, grammatico del II secolo d.C., il Foro, che era anche un mercato, era servito da canali di scolo, dove si radunavano i poveri e i senzatetto, e che per questo erano chiamati "i canalicoli forensi".
Il Foro era utilizzato anche come mercato.
 Tempio di Saturno e Arco di Settimio Severo tra il 1890 e il 1900
Tempio di Saturno e Arco di Settimio Severo tra il 1890 e il 1900
La pavimentazione
Il Foro Romano fu probabilmente pavimentato nei primi anni del periodo etrusco, verso la fine del VII secolo a.C. La piazza fu poi ripavimentata più volte durante l'epoca repubblicana - resti di questo periodo sono stati rinvenuti in vari punti. Tuttavia, il professor Andrea Carandini, in tutti i suoi anni di scavi, ha trovato una stratigrafia che risale a strati più antichi e che dimostra che la prima pavimentazione del Foro risale all'VIII secolo a.C. (La Repubblica, 21.2.2005). Il pavimento visibile è datato intorno al 12 a.C. da una grande iscrizione, parzialmente conservata perché restaurata, sulla colonna di Foca. Conservata anche in rilievo nei Musei Capitolini, essa fa riferimento a L. Naevius L. f . Surdinus pr., uno dei mediatori tra i Romani e gli stranieri dell'epoca.
L'iscrizione è in onore di questo patrono dei pavimentatori, come si può vedere in altre colonie romane (ad esempio Terracina, Sepino, Velleia). L'incendio avvenne nel 12 a.C. - la Basilica Emilia bruciò insieme alla maggior parte del Foro (la sede laterale della Basilica Giulia, il Tempio di Vesta e la Casa dei Castori), quindi sarebbe stata necessaria una nuova sistemazione. Tra la Rostra e il Lacus Curtius si trovano alcuni pavimenti piuttosto grandi risalenti all'epoca di Cesare. Sono presenti anche dei fori che rivelano l'esistenza di un sistema di tunnel che attraversava l'intero Foro nello stesso periodo.
Durante gli scavi sono stati rinvenuti dispositivi di sollevamento in legno, collegati all'uso del Foro per i combattimenti dei gladiatori in epoca repubblicana. Questi fori furono chiusi dalla pavimentazione di Surdinus e fu in questo momento storico che fu costruito il primo anfiteatro permanente, chiamato arena di Statilio Taurus, nel Campo Marzio. La Colonna di Foca, l'ultimo monumento costruito nel Foro, dimostra che il livello del suolo era lo stesso dell'epoca augustea nel 608 d.C. In una piazza non pavimentata di fronte alla Rostra, un tempo si trovavano gli alberi simbolici del fico, dell'olivo e della vite.
Furono collocati lì in un secondo momento. È anche possibile che la statua di Marsia, visibile nei rilievi di Traiano nella Curia Iulia, fosse stata inizialmente collocata qui. Accanto all'iscrizione di Surdunus, a un livello inferiore, si trova un pavimento di epoca cesarea che in alcuni punti rivela uno strato ancora più antico di blocchi di tufo. A est si trova un dodecagono costruito in cappellaccio (tufo friabile) con una base circolare che presenta al centro un'apertura che si ritiene fosse un pozzo, probabilmente quello del Lacus Curtius.
Servizi e accessibilità
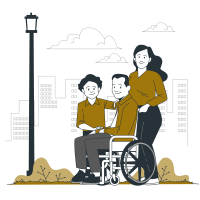
Accessibile con sedia a rotelle

Servizi igienici

Libreria

Punto di ristoro

Pit Stop per neonati

Audioguida
Come arrivare
Orari di apertura
1-25 ottobre dalle 8:30 alle 18:30
26 ottobre - 31 dicembre dalle 8:30 alle 16:30
