Il Colosseo

L'anfiteatro è chiamato Amphitheatrum Flavium in latino e semplicemente Amphitheatrum in italiano (Anfiteatro). È il più grande anfiteatro romano del mondo, con una capienza stimata tra i 50.000 e gli 87.000 spettatori. Questo lo colloca proprio nel cuore del più imponente anfiteatro romano di Roma, che è anche il più imponente relitto dell'antichità giunto fino a noi.
È stato inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel 1980, insieme all'intero centro storico di Roma, alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede in Italia e alla Basilica di San Paolo fuori le Mura. Successivamente, nel 2007, è stato scelto come una delle Nuove Sette Meraviglie del Mondo in un concorso organizzato dalla New Open World Corporation (NOWC). Costruito durante il regno dei Flavi su un terreno situato all'estremità orientale del Foro Romano, l'anfiteatro fu iniziato da Vespasiano nel 70 d.C. e completato da Tito, che lo inaugurò il 21 aprile 80 d.C. La sua costruzione fu infine completata, con alcune modifiche, da Domiziano nel 90 d.C.
La storia in prospettiva
Iniziato negli anni 70-72 dall'imperatore Vespasiano della dinastia dei Flavi, fu finanziato, come tutte le altre opere pubbliche dell'epoca, con le tasse provinciali e anche con il bottino della conquista del Tempio di Gerusalemme nel 70. Il sito scelto era nella conca tra Velia, il colle Oppio e il Celio, dove si trovava un lago artificiale - che il poeta Marziale chiama "lo stagnum" - scavato da Nerone per la sua Domus Aurea. La piscina, o meglio il bacino idrico, era alimentata da sorgenti provenienti dalla base del Tempio del Divino Claudio sul Celio. Vespasiano lo nascose come opera di riparazione per invertire le politiche del tiranno. Nerone aveva privatizzato terreni pubblici per uso proprio, mostrando ciò che era stato e ciò che sarebbe stato in termini di forme di governo. Vespasiano deviò l'acquedotto per uso civico, restaurò il lago e migliorò le fondamenta su cui era stata costruita la Cavea.
Prima della sua morte, nel 79, Vespasiano fece completare i primi due livelli e inaugurò con successo la struttura. Questo fu il primo grande anfiteatro permanente di Roma, dopo due più piccoli o più temporanei del periodo giulio-claudiano (l'Anfiteatro del Toro e l'Anfiteatro di Caligola), e fu costruito ben 150 anni dopo la costruzione dei primi anfiteatri in Campania. Tito innalzò anche le gradinate fino al terzo e quarto livello e lo inaugurò ufficialmente con 100 giorni di spettacoli nell'80. Poco dopo, furono apportate modifiche massicce dall'altro figlio di Vespasiano, l'imperatore Domiziano, a cui si attribuisce il completamento dell'ad clipea - probabilmente scudi di bronzo dorato - e forse l'aggiunta del maenianum summum in ligneis, nonché la costruzione dei passaggi sotterranei dell'arena. Dopo questi miglioramenti, l'anfiteatro non fu più utilizzato per le naumachiae, ovvero la messa in scena di battaglie navali, che, secondo fonti storiche, avevano avuto luogo poco tempo prima.
Insieme alla costruzione dell'anfiteatro, furono realizzate diverse altre strutture per i giochi: i ludi (che fungevano da caserme e campi di addestramento per i gladiatori - Magnus, Gallicus, Matutinus e Dacicus), le caserme per il contingente di marinai della Classis Misenensis - la flotta romana di stanza a Miseno, che gestiva il velarium (castra misenatium), il summum choragium e l'armamentaria - magazzini per armi e attrezzature. C'era anche un sanatorio - un luogo dove venivano curate le ferite riportate in battaglia - e uno spoliarium, dove venivano conservati i resti dei gladiatori uccisi in combattimento. L'edificio ha la forma di un ovale policentrico, con una lunghezza massima di 527 metri, una larg hezza massima di 187,5 metrie due assi di 156,5 metri. L'interno dell'arena misura 86 metri per 54, per una superficie totale di 3.357 metri quadrati.
Ciò che oggi emerge dal terreno per formare questa struttura è alto 48 metri, anche se in origine era alto 52 metri. Questa struttura testimonia chiaramente i veri principi naturali alla base dei progetti architettonici e ingegneristici romani durante il primo periodo imperiale, con la grandiosa linea avvolgente della pianta ellittica e i metodi di costruzione dettagliati utilizzati. Gli archi e le volte sono strutturalmente interconnessi in modo interessante. Nell'antichità qui si svolgevano i giochi gladiatori. Il pubblico poteva assistere a diversi tipi di spettacoli: cacce agli animali e naumachie, battaglie navali, rievocazioni di battaglie famose e drammi basati sulla mitologia. Cadde in disuso dopo il VI secolo, ma nel corso del tempo trovò vari utilizzi, in particolare come cava. Oggi è un simbolo di Roma e, in quanto monumento archeologico visitabile, una delle sue principali attrazioni.
 Antico Impero Romano Colosseo
Antico Impero Romano Colosseo
L'epoca imperiale
I lavori di Nerva e Traiano sono attestati da diverse iscrizioni, ma fu sotto Antonino Pio che iniziò la prima fase di restauro. Nel 217, probabilmente a causa di un incendio provocato da un fulmine, le strutture superiori furono danneggiate, causando la chiusura del Colosseo per 5 anni, dal 217 al 222, durante i quali i giochi si svolsero nel Circo Massimo. Il restauro iniziato da Eliogabalo (218-222) fu continuato da Alessandro Severo, che ricostruì il colonnato sulla summa cavea.
Sebbene l'edificio fosse stato riaperto nel 222, solo durante il regno di Gordiano III il restauro poté essere considerato completo, come sembra confermare il conio delle monete di questi due imperatori. Un altro incendio nel 250, causato ancora una volta da un fulmine, spinse l'imperatore Decio a ordinare dei lavori di riparazione. Dopo il sacco di Roma da parte dei Visigoti nel 410 sotto Alarico, si ritiene che un'iscrizione in onore dell'imperatore Onorio sia stata aggiunta al podio che circondava l'arena nell'ambito dei lavori di restauro. Fu Onorio a porre fine ai giochi gladiatori e a consentire in seguito lo svolgimento di spettacoli di caccia nell'arena.
L'iscrizione fu rimossa dopo qualche tempo e sostituita per commemorare un altro importante restauro, seguito a un terremoto nel 442, sotto i prefetti Flavius Sinesius Gennadius Paulus e Rufius Cecina Felix Lampadius. Costanzo II la trovò di suo grande gradimento. Ulteriori restauri furono effettuati nel 470 dal console Messio Febo Severo dopo un altro terremoto. I lavori continuarono anche dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente; dopo un altro terremoto nel 484 o nel 508, Decio Mario Venanzio Basilio, allora praefectus urbi, pagò personalmente il restauro.
Le venationes continuarono fino al tempo di Teodorico. Gradus ha inciso i nomi delle grandi famiglie senatoriali dell'epoca di Odoacre; sebbene si trattasse di un'usanza antica, i nomi venivano costantemente cancellati e sostituiti da quelli dei nuovi occupanti secondo i vari ordini dei clarissimi, spectabilis e illustres. Tutto ciò che rimane sono i nomi dell'ultima edizione prima della caduta dell'Impero.

Dal Medioevo all'età moderna
Fu utilizzato inizialmente come necropoli nel VI secolo e successivamente come castello. Tra il VI e il VII secolo, all'interno del Colosseo fu costruita una cappella, oggi nota come Santa Maria della Pietà al Colosseo. Intorno all'847, durante il regno di Papa Leone IV, un terremoto causò gravi danni alla struttura.
Fu soprattutto la parete esterna meridionale a crollare durante un forte terremoto nel 1349: questa parte era stata costruita su un terreno alluvionale meno solido. Nel XIII secolo il Colosseo fu utilizzato come cava e fu anche sede di un palazzo appartenente alla famiglia Frangipane, che fu poi demolito, ma non fu mai disabitato: il Colosseo continuò ad ospitare molte altre abitazioni umane. Durante il XV e il XVI secolo, i blocchi di travertino furono sistematicamente rimossi per costruire nuovi edifici. Nel 1451, il travertino, gli asproni e il marmo del Colosseo furono scavati, frantumati e portati nei forni da calce di papa Niccolò V. Il lavoro fu commissionato dal M° Giovanni di Foglia Lombardo.
Le pietre cadute a terra furono utilizzate per costruire Palazzo Barberini nel 1634 e, dopo un altro terremoto nel 1703, per costruire il porto della Ripetta. Benvenuto Cellini, nella sua autobiografia, racconta una notte terrificante tra gli spiriti evocati all'interno del Colosseo per dimostrare quanto fosse malvagio e minaccioso quel luogo. Durante l'anno giubilare del 1675, il luogo fu consacrato in memoria dei numerosi martiri cristiani che vi avevano sofferto. Fu un decreto di papa Benedetto XIV nel 1744 a porre fine al saccheggio e a dare origine ai quattordici santuari della Via Crucis sul sito; nel 1749 egli dichiarò inoltre il Colosseo chiesa dedicata a Cristo e ai martiri cristiani.
I tempi moderni: il ritorno al XIX secolo
Il Colosseo era già stato scavato in due fasi principali - prima da Carlo Fea, Commissario delle Antichità, nel 1811 e 1812, poi da Pietro Rosa tra il 1874 e il 1875 - diventando oggetto di vari progetti di riutilizzo fantasioso fino alla metà del XVIII secolo.
Alla fine del XIX secolo, dopo secoli di utilizzo, tra cui un periodo di culto cristiano all'interno delle sue mura e l'uso come cava di travertino, questa grande struttura era rimasta su fondamenta molto precarie. Il problema più evidente è la brusca discontinuità dell'anello esterno lungo i tratti adiacenti alle strade odierne, Via di San Giovanni in Laterano e Via dei Fori Imperiali, soprattutto dove sono stati effettuati importanti restauri. Fea registra anche quella che potrebbe essere l'origine dei fori nelle pietre del monumento, probabilmente parte di un meccanismo per estrarre i morsetti metallici che tenevano insieme le pietre.

Origini del nome attuale
Il nome Colosseo divenne popolare nell'alto Medioevo, probabilmente da una volgarizzazione dell'aggettivo latino"colosseum", che significa colossale, in riferimento alle abitazioni a uno o due piani che furono aggiunte in quel periodo. È più probabile, tuttavia, che il nome derivi dalla colossale statua di Nerone situata nelle vicinanze. L'edificio divenne ben presto il simbolo di una città imperiale, dove l'ideologia e il desiderio di celebrare tracciavano gli standard del tempo libero e dell'intrattenimento pubblico.
Nelle vicinanze si trovava una grande statua in bronzo di Nerone, da cui il Colosseo avrebbe preso il nome, un legame documentato fin dal Medioevo e che si riferisce anche alle dimensioni gigantesche dell'edificio. Dopo la morte di Nerone, la statua fu trasformata in quella di Sol Invictus, il dio del sole, con l'aggiunta di raggi di una corona solare intorno alla testa. Nel 126 fu spostata dalla sua collocazione originaria nell'atrio della Domus Aurea da Adriano per far posto al Tempio di Venere e Roma.
Una base moderna in tufo segna il punto in cui si trovavano le fondamenta della colossale statua dopo il suo trasferimento. All'epoca dell'Impero, l'enorme statua di Nerone fu abbattuta ed è improbabile che qualcuno nel VI secolo potesse ricordarla. Nel XIV secolo, il notaio e giudice Armannino da Bologna affermò che il Colosseo era il luogo pagano più importante del mondo.
Le sue parole significano che "il Colosseo era diventato il quartier generale di varie sette di maghi e adoratori del diavolo" e che alle persone che si avvicinavano veniva chiesto "Colis Eum?" (che significa "Lo adori?"). Successivamente, papa Benedetto XIV fece purificare il Colosseo con un esorcismo e gli diede un nuovo uso in memoria delle sofferenze di Cristo e di tutti i santi.

La struttura
La base poggia su un pavimento in pietra rialzato rispetto al terreno circostante. Le sue fondamenta affondano in un grande blocco di tufo, spesso circa 13 metri, ricoperto all'esterno da un muro in mattoni. La struttura portante è costituita da colonne in pietra travertina collegate tra loro da perni metallici. Dopo che l'edificio cadde in disuso, si diffuse l'abitudine di rimuovere questi elementi metallici per fonderli e riutilizzarli, quindi i blocchi furono scavati in corrispondenza dei giunti.
Questo spiega i numerosi fori visibili sulla facciata esterna. I pilastri sono collegati da muri realizzati con blocchi di tufo nella parte inferiore e mattoni nella parte superiore. La cavea è sostenuta da volte a botte trapezoidali e archi poggianti su colonne di travertino e tramezzi radiali in tufo o mattoni. All'esterno è utilizzato il travertino, visibile in una serie di anelli concentrici che sostengono la cavea.
Queste cortine sono decorate con una serie di archi incorniciati da pilastri. Le volte a crociera sono tra le prime nel mondo romano, realizzate in opus caementicium e molto spesso con nervature di archi in mattoni incrociati, utilizzati anche nei rivestimenti. Inoltre, le pareti radiali all'esterno dei due ambulacri esterni sono rinforzate con blocchi di tufo. Un avanzato sistema di approvvigionamento idrico e di drenaggio contribuiva alla manutenzione dell'edificio e forniva acqua alle fontane situate nella cavea per il pubblico.

Facciata esterna
La facciata esterna (che raggiunge i 48,50 metri) è realizzata in travertino ed è disposta su quattro ordini, seguendo lo schema tipico di tutti gli edifici di rappresentanza del mondo romano: i tre livelli inferiori sono costituiti da 80 archi numerati sostenuti da semicolonne. Il quarto livello (attico) è costituito da un muro pieno con pilastri corrispondenti alle colonne degli archi. Le colonne di ogni livello sono doriche, ioniche e corinzie. Anche l'ultimo piano è corinzio.
Le sezioni murarie tra i pilastri contengono 40 piccole finestre quadrate, una ogni due campate (le campate piene erano sempre dotate di morsetti in bronzo). Sopra le finestre, ogni campata presenta tre mensole sporgenti. Queste mensole ospitavano le aste di legno utilizzate per aprire e chiudere i lucernari. Probabilmente erano ancorate al suolo da una serie di blocchi di pietra inclinati. Questi ingressi sono ancora visibili oggi sul bordo esterno della terrazza di travertino su cui sorge il Colosseo (quello sul lato del Celio è chiaramente visibile). Il primo livello terrazzato conteneva 80 ingressi, compresi quattro ingressi speciali lungo l'asse ellittico.
L'asse corto conteneva gli ingressi alle tribune VIP (l'ingresso dell'imperatore); l'asse lungo conteneva gli ingressi diretti all'arena. Diversi piani erano riservati alle diverse classi sociali. L'imperatore sedeva al mattino su una piattaforma di fronte all'Arco di Costantino e al pomeriggio su una piattaforma di fronte a quella che oggi è una stazione della metropolitana. Gli archi del secondo e terzo piano erano incorniciati da parapetti continui con semicolonne con basi cubiche.
I quattro stili di semicolonne e pilastri, dal basso verso l'alto, avevano capitelli toscani, ionici, corinzi e corinzi lisci. I primi tre stili ripetono lo stesso ordine, una sequenza che si ritrova anche sulla facciata del Teatro di Marcello. Le monete mostrano quattro archi alle estremità dell'asse ellittico della pianta, decorati con un piccolo portico in marmo.

Il velario
Il Colosseo aveva un tetto in tessuto, chiamato velario, composto da molti teli che, secondo alcuni studiosi come Manzione, coprivano le tribune degli spettatori, lasciando l'arena centrale aperta al cielo. Questo avrebbe fornito ombra agli spettatori solo a mezzogiorno; in tutti gli altri momenti della giornata, diverse parti delle tribune avrebbero continuato a ricevere la luce solare diretta. Altri studiosi (D'Anna e Molari) hanno proposto una versione completamente coperta, compresa l'arena. Il velarium era progettato per proteggere gli spettatori dal sole ed era azionato da un gruppo di marinai della flotta di Miseno, che aveva base vicino al Colosseo.
Per mantenere i teli in posizione veniva utilizzato un sofisticato sistema di funi e carrucole. Manzione e altri ritengono che il tutto fosse tenuto in posizione da funi fissate a blocchi di pietra all'esterno del Colosseo, alcuni dei quali sono ancora visibili oggi. Tuttavia, recenti scavi nella zona hanno rivelato che questi blocchi non hanno fondamenta, quindi questa ipotesi è stata scartata.

Accesso all'auditorium e alle aree pubbliche
La cavea è costituita da sedili e gradinate in marmo per gli spettatori. È interamente realizzata in marmo ed è divisa da praecinctiones o baltea (divisori) in cinque sezioni orizzontali (maeniana) assegnate a diverse categorie di spettatori in ordine crescente: il rango diminuiva man mano che si saliva, a quanto pare. Nella parte superiore c'erano ampi gradini bassi per sedili di legno (subsellia) dove sedevano i senatori e le loro famiglie, e i nomi dei senatori a cui erano stati assegnati questi posti inferiori erano incisi sulla balaustra del podio. Seguiva il maenianum primum, con una ventina di gradini in marmo, e il maenianum secundum, diviso in imum (inferiore) e summum (superiore), ciascuno con circa sedici gradini in marmo. All'interno del portico colonnato che coronava la cavea (porticus in summa cavea), c'erano circa undici gradini in legno.
Ciò che rimane dal punto di vista architettonico appartiene a una ristrutturazione del periodo severiano o gordiano III. Era su questi gradini che le donne sedevano sotto un tetto, separate dal resto degli spettatori fin dai tempi di Augusto. Il posto meno ambito era sulla terrazza sopra il colonnato, dove i posti in piedi erano riservati alle classi più basse della plebe. Le scale e gli ingressi alla cavea dividevano verticalmente i settori. Erano protetti da barriere di marmo risalenti al restauro del II secolo. Ad ogni estremità dell'asse minore, preceduto da una sezione frontale, c'erano due palchi per personaggi importanti, oggi scomparsi. Uno, a forma di "S", era riservato all'imperatore, ai consoli e alle vergini vestali; l'altro era destinato al praefectus urbi e ad altri dignitari. Dopo aver attraversato gli archi d'ingresso, raggiungevano i loro posti.
Gli imperatori e i funzionari esercitavano il loro diritto di ingresso riservato sull'asse minore dell'ovale, mentre gli ingressi centrali sull'asse maggiore erano riservati agli attori e ai protagonisti degli spettacoli. Tutti gli altri spettatori dovevano mettersi in fila sotto questo arco secondo il numero del biglietto, quindi ogni arco pubblico aveva un numero inciso sulla chiave di volta. Tale numerazione rendeva più facile e veloce raggiungere il proprio posto. I numeri incisi sugli archi del Colosseo erano dipinti di rosso per renderli più visibili da lontano.
Questo dettaglio è venuto alla luce durante i lavori di restauro finanziati dal gruppo Tod's, quando la facciata è stata pulita con acqua nebulizzata per rimuovere lo sporco e i depositi di smog e riportare alla luce alcune tracce di colore molto tenui. Da qui, una serie di scale incrociate conduceva a una disposizione simmetrica di corridoi circolari a volta. Ciascuno di questi conduceva a un grande cuneo tripartito diviso da pilastri, pareti di passaggio rivestite in marmo e un soffitto a volta con decorazioni in stucco, originale del periodo flaviano. Inoltre, il palco meridionale dell'imperatore ha un altro ingresso attraverso un criptoportico che conduce direttamente all'esterno. Dodici archi si aprivano su corridoi utilizzati da coloro che sedevano nell'anello più interno, da cui una breve scala conduceva alla parte inferiore della cavea. Anche questi passaggi erano rivestiti in marmo. Gli archi rimanenti davano accesso a diverse scale singole o doppie che conducevano alle zone superiori. In questa zona, le pareti erano rivestite in gesso, che arrivava fino alle volte.

L'arena e le aree di servizio sottostanti
L'arena ovale (86 m x 54 m) era costruita in mattoni e legno e ricoperta di sabbia, che veniva pulita frequentemente per assorbire il sangue degli animali uccisi. L'arena era separata dalle tribune degli spettatori da una piattaforma alta circa 4 metri, decorata con nicchie e marmo e protetta da una ringhiera in bronzo. Dietro la piattaforma si trovavano i posti a sedere principali. L'arena conteneva varie trappole e ascensori che conducevano a passaggi sotterranei utilizzati durante gli spettacoli.
Sotto l'arena si trovavano le aree di servizio (catacombe), divise in un grande corridoio centrale lungo l'asse principale e dodici corridoi curvi disposti simmetricamente su entrambi i lati. Gli ascensori venivano utilizzati per portare nell'arena le macchine o gli animali utilizzati nei giochi. C'erano 80 ascensori distribuiti su quattro corridoi. I resti sopravvissuti indicano che l'edificio fu ricostruito nel III o IV secolo d.C. Il confronto con i passaggi sotterranei dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (costruito dallo stesso architetto del Colosseo) dà un'idea di come potessero essere i passaggi sotterranei del Colosseo in epoca romana. A Pozzuoli sono ancora visibili i dispositivi utilizzati dai Romani per trasportare le gabbie degli animali selvatici nell'arena. Il tetto dei passaggi sotterranei non esiste più, quindi le stanze sotto l'arena sono ancora visibili oggi. Gli edifici di servizio sotto l'arena avevano ingressi separati:
Le gallerie sotterranee alla fine dell'asse principale conducevano al passaggio centrale sotto l'arena, utilizzato per il trasporto di animali e macchinari. Due imponenti ingressi ad arco sull'asse principale conducevano direttamente nell'arena, consentendo l'accesso ai protagonisti (pompa), ai gladiatori e agli animali troppo pesanti per essere sollevati attraverso i passaggi sotterranei. Il personale poteva anche accedere all'arena attraverso passaggi aperti nelle gallerie di servizio, che circondavano l'arena e si trovavano sotto il podio sotto l'auditorium. I corridoi circolari più interni conducevano alla galleria, dove sedevano i senatori.

Santa Maria della Pietà al Colosseo
All'interno del Colosseo si trova la chiesa di Santa Maria della Pietà al Colosseo, luogo di culto cattolico. Si tratta di una chiesa semplice costruita in uno degli archi dell'anfiteatro flavio. La sua fondazione può essere datata tra il VI e il VII secolo, ma probabilmente non è così, poiché le prime notizie certe della sua esistenza risalgono al XIV secolo.
È sempre stata un luogo di culto in memoria dei martiri cristiani morti all'interno del Colosseo, e molti santi l'hanno visitata, tra cui Sant'Ignazio di Loyola, San Filippo Neri e San Camillo de Lellis, solo per citarne alcuni. Secondo l'archeologo romano Mariano Armellini, "la cappella era in origine un camerino per la compagnia che rappresentava l'importante dramma della Passione di Cristo nell'anfiteatro fino al tempo di papa Paolo IV". Nel 1622, quindi, il santuario passò in possesso della Confraternita del Gonfalone, che vi costruì l'oratorio e vi installò un monaco come custode per prendersi cura del luogo. Nel 1936 il Vicariato di Roma affidò al Circolo San Pietro la cura della liturgia di questa chiesa.

I giochi dei gladiatori
Il Colosseo ospitava eventi sportivi in stile anfiteatro, tra cui combattimenti tra animali (venationes), esecuzioni da parte di animali selvatici o con altri metodi (noxii) e combattimenti tra gladiatori (munera). Questi eventi seguivano un programma fisso: al mattino si svolgevano i combattimenti tra animali o tra gladiatori e animali, a mezzogiorno le esecuzioni e nel pomeriggio i combattimenti tra gladiatori.
Per celebrare il completamento del Colosseo, l'imperatore Tito organizzò una serie di giochi della durata di tre mesi che coinvolsero circa 2.000 gladiatori e 9.000 animali. Per celebrare la vittoria di Traiano sui Daci, parteciparono 10.000 gladiatori.
L'ultimo combattimento gladiatorio documentato ebbe luogo nel 437 d.C. Tuttavia, l'anfiteatro continuò ad essere utilizzato per il massacro di animali fino al regno di Teodorico il Grande: gli ultimi combattimenti gladiatori ebbero luogo nel 519 durante il regno di Eutalico (genero di Teodorico) e nuovamente nel 523 durante il regno di Anisio Massimo. Gli scavi nelle fogne del Colosseo hanno portato alla luce i resti di molti animali domestici e selvatici, tra cui orsi, leoni, cavalli e struzzi.
Servizi e accessibilità
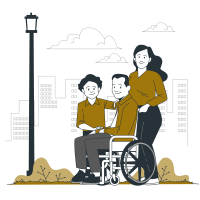
Accessibile con sedia a rotelle

Servizi igienici

Libreria

Punto di ristoro

Pit Stop per neonati

Audioguida
Come arrivare
Orari di apertura
1-25 ottobre dalle 8:30 alle 18:30
26 ottobre - 31 dicembre dalle 8:30 alle 16:30
